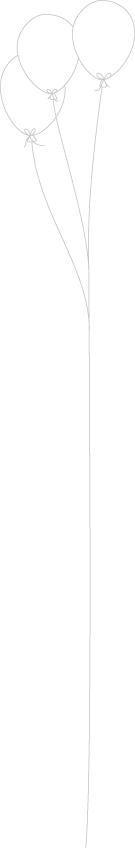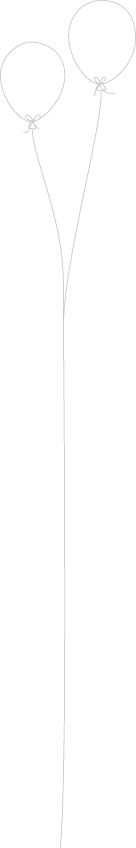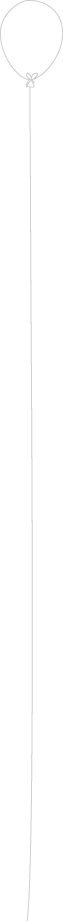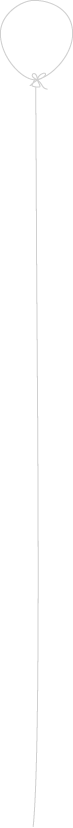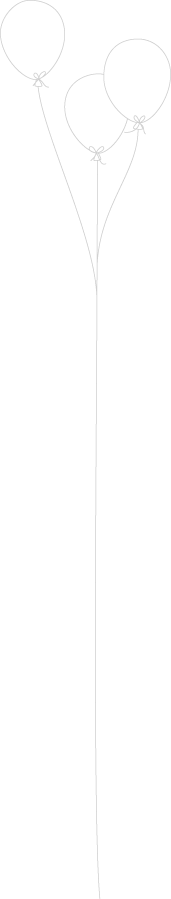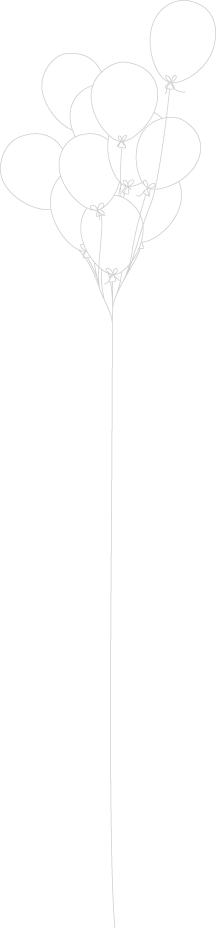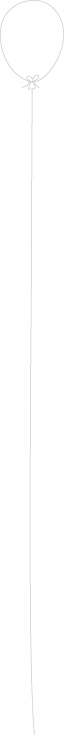Ok.
Attimi di quotidiana schizofrenia.
Metto sù la moka, una prosperosa cinquetazze dal ventre generoso. Sono inebriata dall’odore della polvere di caffè. E ho detto odore.
Un profumo ti piglia il cuore, la mente, i ricordi.
L’odore va dritto ai sensi. E’ qualcosa di molto più istintivo e primordiale. E’ qualcosa che stuzzica le pulsioni. E per questo ho detto odore.
Infiammo il fornello senza particolari difficoltà. Abituata a certi clichè romani (ricerca dell’accendino, prova dell’accendino, constatazione dolorosa della non fungibilità dell’accendino, richiesta dell’ausilio tecnico di coinquilini vari ed eventuali) mi sembra un semi miracolo. Mi sento una novella Prometea.
Il caffè è un rito, e non lo dico perchè sono del sud, nè perchè sono un’appassionata e sentimentale cultrice di Eduardo de Filippo.
Ci vuole una meticolosità tutta rituale per farlo venire buono.
Richiede lentezza.
Quando lo sento gorgheggiare mi appresto a sollevare la moka dalla fiamma: deve uscire lento, il calore non lo deve forzare (e mi viene in mente qualcosa di affine, ma mi asterrò dal farci cenno), deve scivolare piano, aggrappandosi alle pareti della moka, misurando il condotto viscidamente. Si deve impregnare di sè. Deve dar prova di tutta la sua viscosità.
Fisso il filino scuro di liquido che scende, mi godo la misticità del momento: se prima o poi mi verrà voglia di credere in qualche dio, sarà il dio del caffè. Quello che porta ad ebollizione l’acqua e, facendole vincere la forza di gravità, la spinge nel filtro, ad impregnarsi di nero e di sapore.
Uno squillo acuto mi disturba: il telefono.
Per quanto lo odi, lo squillo compulsivo del telefono mi getta in uno stato di ipertensione cosmica. Rispondere si configura come necessità assoluta.
Mollo la moka sul fuoco, stizzandomi per lo scempio che quella temperatura troppo alta e quella risalita troppo rapida imporranno al mio nettare, e corro.
Mi fiondo sul coardless. Esso non trilla. Ci metto qualche secondo a realizzare che è scarico: dimenticato lontano dalla base probabilmente da giorni.
Raggiungo il primo fisso che mi trovo a tiro.
Ma è tardi. E’ muto.
Di fretta compongo il 400. Ascolto la fastidiosa voce di seta della signorina virtuale, che immagino come una crisalide in un bozzolo di tulle rosa. Riconosco il numero.
Un 333 storico che mi appresto a richiamare.
Con foga, aggiungerei.
Un’altra voce di seta mi risponde. Non c’è campo, oppure ha spento. Insomma non c’è nulla da fare, fai un po’ tu.
Breve cenno cerebrale all’ineluttabilità del destino e all’assoluta inutilità di ritentare.
Certe cose sono come le onde: vanno e vengono, e quando ritornano non sono mai le stesse, acque bastarde, acque diverse.
L’odore di bruciato viene a prendermi per mano fin giù alle scale. (Un altro odore: stuzzica le corde della rabbia, questa volta). Tiro giù un paio di santi, giusto per non esser da meno.
Lo faccio per clichè, interpreto la me stessa incazzata e vile. E mentre lo faccio un altro paio di me (l’osservartice e il censore) motteggiano di gusto:
– Smettila di bestemmiare!
– Che ti frega, tanto manco crede!
– Appunto, che senso ha?
– Sta recitando, non lo vedi?
– Sì, vedo. Recito anch’io, non te ne accorgi?!
Intimo a tutte quelle me di tacere. E preparo l’aria più sentitamente tragica che ho.
Le mattonelle della cucina sono tempestate di lentiggini, e la moka emette un rantolo sofferente. Spengo tutto, ci dò di spugnetta.
Maledico tra me, me e me quel 333 e il suo titolare frettoloso. O confuso. Confuso e frettoloso. Frettolosamente confuso. Confusamente frettoloso.
Come me.
Carico di nuovo la moka, chè c’è sempre tempo per un caffè.