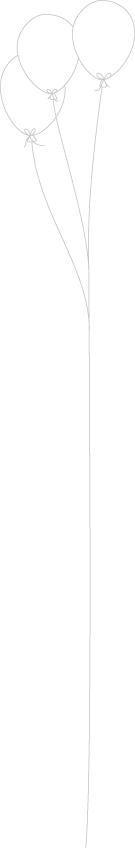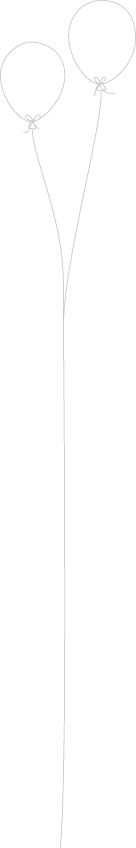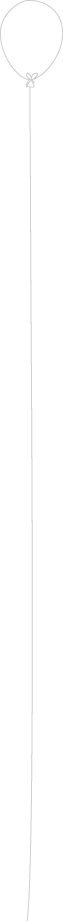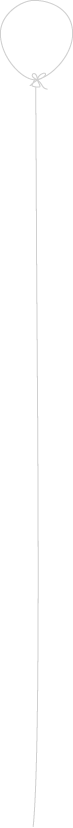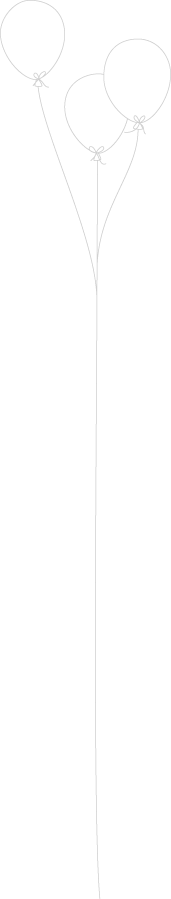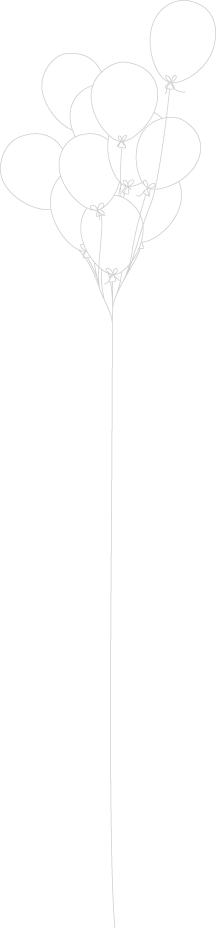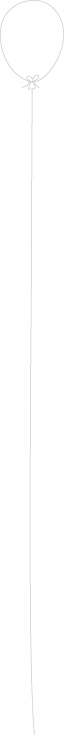Non temo gli spoiler e non sono una fanatica dell’alta fedeltà, così questo film – come tanti altri film – l’ho visto male.
In un pomeriggio bloccato sul fondo da un treno che non si può ma si vorrebbe perdere, con dieci giorni d’interruzione tra i primi quaranta minuti e il resto, dieci giorni nei quali mi sono rimpinzata di recensioni discordanti, entusiasmi da status su Facebook, trame di Wikipedia in più di due lingue, spotifàici loop della colonna sonora.
Dei primi quaranta minuti di visione ne ho pianti venti. I dialoghi e i lunghi intensi piani venivano giù morbidi e precisissimi e i colori sgualciti e le luci nebulose (e anche i pungenti pantaloni a vita alta, che se t’impegnavi potevi sentirli sfregare in scintille i peli delle cosce) e la voce di Lei e l’impacciata malinconia di lui, anche.
Di film ne capisco quasi niente, con le emozioni me la cavo.
La seconda visione ha avuto un tempo e un luogo suoi propri e un aperitivo di scaglie di pecorino, amore e vino buono a precederla. E ho scoperto che senza l’ansia dell’inizio io – la signora delle Prime Volte – i film me li godo di più.
Rivedere i primi quaranta minuti di Her è stato rassicurantemente bello: ho aspettato, compita, di piangere ai ricordi della conclusa vita matrimoniale (letti riposizionati, mani al collo e I love you so much I’m gonna fucking kill you) e ho sorriso complice ai timori di Theodore sul grado delle emozioni future e sulla paura di aver provato già tutto quello che di più forte c’è da provare e di doversi rassegnare ad un destino di sensazioni sfumate, figlie minori di quelle ormai trascorse. E ho capito il compiacimento di Samantha nel sentire di avere delle emozioni: la gelosia, l’interesse, la preoccupazione per qualcuno. Perché non bisogna essere necessariamente un sistema operativo per compiacersi e stupirsi nello scoprire di avere un cuore e di saperlo far funzionare, no. Basta essere un po’ schivi, basta aver elucubrato un po’ troppo, basta convincersi di essere meno umani dell’indefinitissimo prossimo tuo.
Poi ho applaudito fortissimo al collega Paul, che ha la fidanzata avvocato e che non trova nulla di strano nel fatto che la fidanzata di Theodore sia un OS, perché l’amore che hai per qualcuno e l’importanza che accordi a qualcosa ne definisce molto meglio la natura di quanto qualsiasi altra caratteristica possa fare (Is it not a real relationship? chiederà Amy a Theodore, suggerendogli la ricerca di una risposta che sia la sua e la sua soltanto). E anche qui non c’è bisogno di frequentare un’intelligenza artificiale per sapere che il valore che attribuiamo alla persona che amiamo va definito e difeso, con sé e tra gli altri. Ma non ho per questo trovato meno condivisibili le accuse di Catherine: amare qualcosa che non esiste nell’accezione classica dell’esistenza pone evidentemente meno problemi – o problemi in parte diversi – rispetto all’amore fatto di letti spostati, di case messe su assieme e di quotidianità non sempre brillanti.
Her mi ha lasciata commossa, sorridente, serena.
Certo, avrei voluto che alla domanda “e di questi ottomila e passa quanti ne ami?” Samantha avesse risposto “solo uno, solo te” (chi non lo vorrebbe?) ma l’alba su Theodore e su Amy – umani, discreti, possibili alla ricerca di un appagamento umano e discreto che si fa forte di quella specificità e quella biunivocità d’intenti nella quale gli esseri umani (e discreti) sublimano i loro limiti e gli OS, evidentemente, no – ha chiuso con onestà il cerchio delle emozioni.
Facendomi considerare che sì,
magari ce la facciamo anche noi.